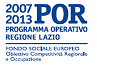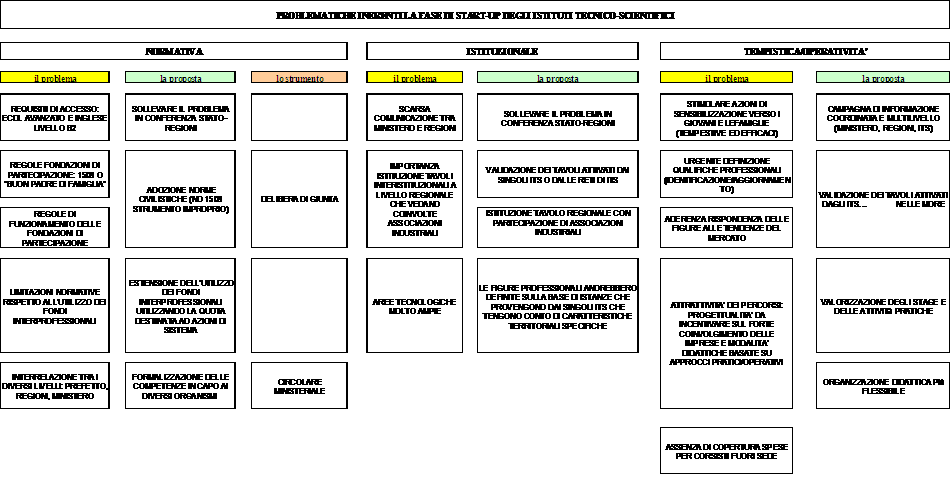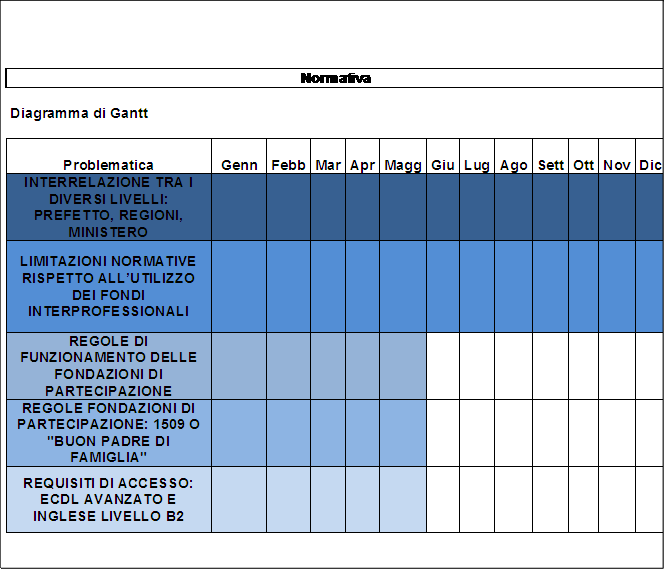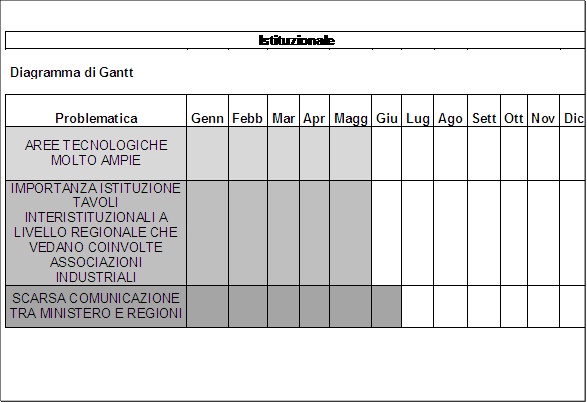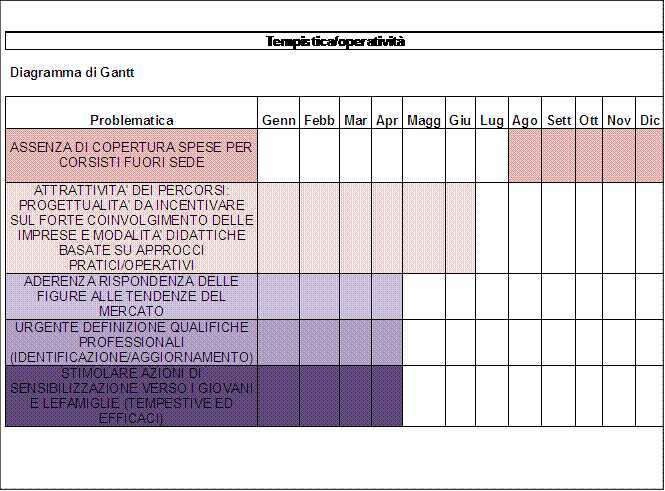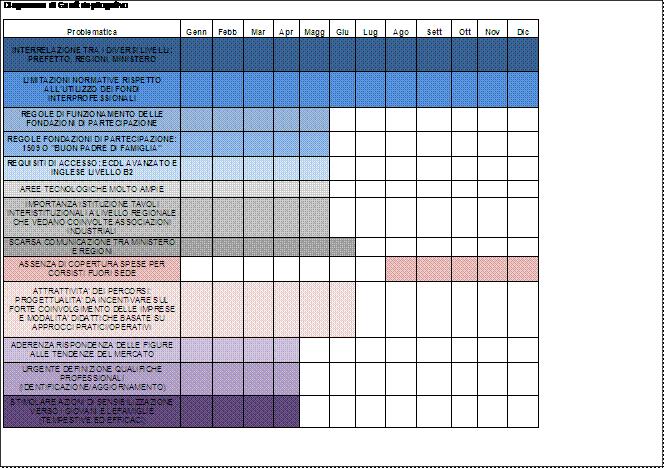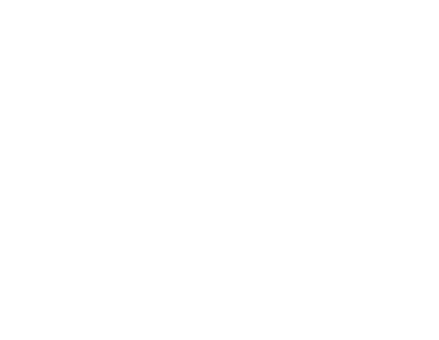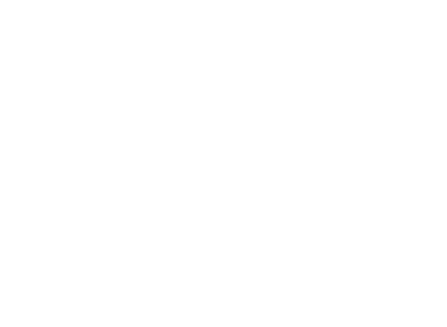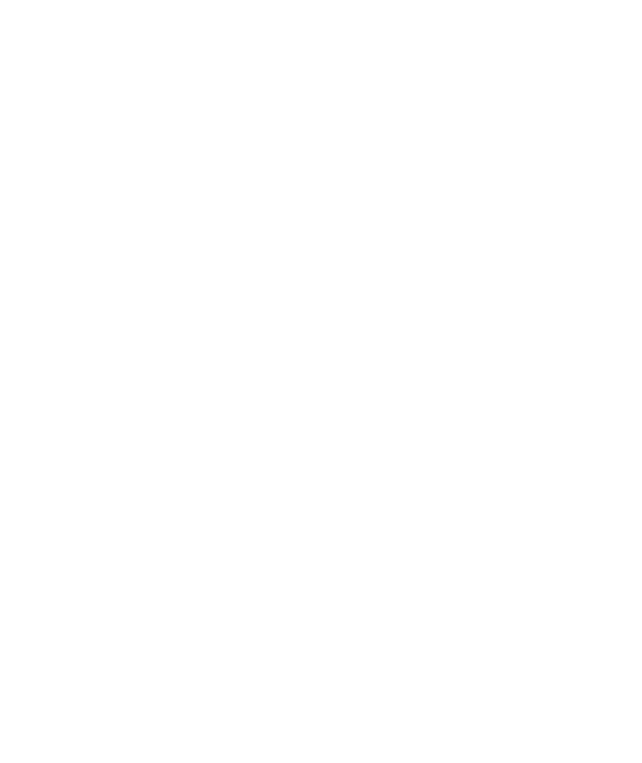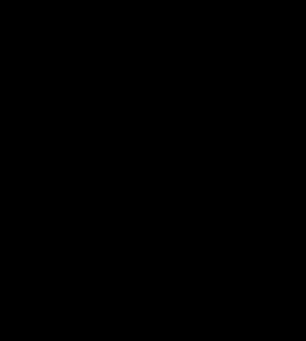|
|
|
|
|
|
|

INDICE
TOC \o "1-3" \h \z \u Premessa
1. GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)
1.2 Le linee-guida della Regione Lazio
1.4 Le proposte per fronteggiare le criticità legate alla fase di start-up degli ITS
2. I PTP TRA PRESENTE E FUTURO
2.1 L’istituzione dei Poli Tecnico Professionali
2.2 Le difficoltà interpretative sull’ istituto
2.3 Il ruolo assegnato ai Poli Tecnico-Professionali
2.4 Un possibile modello di governance
2.5 Il modello del Polo di Settore
2.6 Un confronto con l’esperienza dei Poli Formativi del Lazio
La globalizzazione e la competizione internazionale richiedono che i diversi soggetti a vario titolo protagonisti dello sviluppo socio-economico si contaminino creativamente per dare luogo a tutte le sinergie possibili. In questo contesto, la conoscenza assume un ruolo sempre più rilevante come strumento di sviluppo e di crescita sociale, specie in una fase storica come la nostra in cui i fattori produttivi del mondo industrializzato non sono più esclusivamente le macchine, il capitale, la forza lavoro, ma la quantità di conoscenza acquisita, trasferita e utilizzata in ogni componente dei prodotti e fase dei processi di produzione.
I lavori sono diventati “cognitivi”, e la conoscenza è diventato il fattore decisivo nella produzione e nell’economia, così che buona parte del futuro economico e civile di un paese si gioca nel nesso tra formazione e professionalità. Anche rispetto al piano più squisitamente individuale, l’acquisizione e il consolidamento di un bagaglio di conoscenze sempre più differenziate e specifiche e in modo continuativo viene ad oggi considerato come l’unico percorso per costruire un reale successo professionale e individuale e per partecipare attivamente alla vita sociale.
Alla luce di questi elementi di sfondo, si è sviluppata una crescente attenzione per l’avvio e lo sviluppo di quel rapporto tra scuola, università, imprese e territorio che si è spesso manifestato in maniera episodica e frammentata ma, laddove è stato realizzato, ha costituito un indiscutibile elemento strategico di successo. Non a caso negli ultimi anni sono stati via via formalizzati normativamente diversi modelli di Poli (i distretti industriali, i poli formativi e IFTS, i poli tecnico-professionali, ITS, etc.), tutte iniziative che testimoniano un notevole sforzo rispetto alle sfide economiche emergenti dell’innovazione e della competitività, ma anche l’accavallarsi di svariate disposizioni legislative ed un notevole disordine normativo e organizzativo.
I distretti industriali sono stati per molto tempo indicati come il modello di sviluppo locale dell’economia italiana in grado di attingere risorse di innovatività e riproducibilità nella società locale retrostante e quindi in grado di valorizzare nel migliore dei modi il made in Italy. Negli ultimi anni, questo modello è stato messo in discussione sebbene i distretti industriali continuino a costituire l’asse portante del sistema produttivo italiano per il contributo che essi forniscono in termini di produzione, occupazione, esportazione; ci si è accorti però che le politiche di marketing dei distretti non sono sufficienti a mantenere un adeguato livello di competitività, ma che quest’ultima può essere consolidata solo attraverso lo sviluppo e l’adozione di modelli di pianificazione di innovazione tecnologica del distretto. Occorre, dunque, che le imprese, pur mantenendo le proprie specificità, stringano alleanze e «facciano sistema» anche a livello internazionale, investendo in programmi di sviluppo comuni e avvalorando i propri differenziali competitivi anche attraverso la costruzione di rapporti con le scuole e le università.
D’altro canto, anche il sistema educativo non può continuare ad esplicarsi in un contesto isolato e autoreferenziale, ma piuttosto deve sempre più confrontarsi con il mondo economico-produttivo, costruendo insieme ad esso programmi di crescita per gli studenti, per i giovani in cerca di lavoro e anche per gli occupati. Questa collaborazione si rende assolutamente necessaria in quanto è in grado di attenuare progressivamente quel differenziale (in parte inevitabile) tra la velocità di evoluzione del sistema produttivo e la capacità di risposta del sistema formativo che ha da sempre rappresentato la causa prima del deficit di professionalità e di specializzazione.
I nuovi modelli di partnership implicano dunque che siano le imprese, insieme al sistema di istruzione e formazione, a disegnare i profili utili al sistema produttivo imprenditoriale.
Accanto e parallelo al processo di internazionalizzazione del mercato del lavoro procede veloce quello dell’internazionalizzazione del sistema educativo, che spinge alla convergenza i vari sistemi nazionali di istruzione, di cui fanno parte integrante quelli finalizzati alla preparazione tecnica e professionale (Vocational Education and Training - VET). Uno degli obiettivi chiave dell’Unione Europea indicati dall’Agenda di Lisbona è infatti quello di far crescere significativamente il numero di cittadini in possesso di una qualifica tecnico scientifica elevata. E in vista di questo obiettivo, per fornire ai cittadini europei una nuova opportunità, facilitandone la mobilità e la formazione anche fuori dal paese di origine, è necessaria la messa a punto di accordi e strumenti relativi alle qualifiche, al riconoscimento e trasferimento dei crediti formativi, alla garanzia reciproca di qualità.
Due sono i documenti principali di questo percorso:
1. il “quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente” (European Qualification Framework - EQF) che è il riferimento condiviso delle qualifiche e dei titoli di studio, che costituisce un framework per facilitare il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche e quindi la mobilità, l’occupabilità e l’integrazione dei cittadini europei;
2. a ciò si aggiunge il nuovo strumento di riconoscimento dei crediti del cittadino in formazione denominato European Credit for Vocational Education and Training (ECVET).
I paesi europei sono dunque da tempo impegnati a ripensare i propri sistemi formativi, in particolare quelli di istruzione tecnica e professionale, in modo coerente con tali dispositivi comunitari. Nel fare ciò il nostro paese si è posto di fronte a quattro nodi cruciali da sciogliere (secondo quanto indicato nel documento finale della Commissione ministeriale per la riorganizzazione degli istituti tecnici e professionali):
1. il recupero di una forte cultura scientifica e professionale;
2. una più forte valorizzazione della cultura del lavoro in chiave di capitale umano e sociale;
3. una adeguata differenziazione e insieme integrazione dei percorsi formativi più direttamente orientati all’entrata nella vita attiva;
4. un rafforzamento delle iniziative di formazione continua.
Questo processo ha richiesto agli istituti tecnici ed a quelli professionali di confrontarsi con un contesto di riferimento contraddistinto da un'evoluzione normativa a più livelli e riprese. Come ben descritto in una serie di lavori di approfondimento realizzati dal Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca[1], dal patto per il Lavoro del 1996, gli impegni assunti con le parti sociali dai Governi che si sono succeduti nel tempo hanno indicato la necessità di modernizzare il Paese attraverso il partenariato istituzionale e sociale per le politiche di sviluppo e per la formazione. Le Leggi n. 196/97 e n. 144/99 hanno segnato l’avvio di questo percorso di innovazione orientato dagli indirizzi dell’Unione Europea in materia di integrazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro.
Il sistema integrato dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), come disegnato e formalmente istituito dall’articolo 69 della Legge n. 144/99, ha improntato il suo percorso di sviluppo a criteri di concertazione istituzionale tra Stato, Regioni ed Enti locali e di dialogo con le parti sociali, in un momento in cui l'intero sistema istituzionale del Paese ha subito riforme in tale senso. Leale collaborazione e sussidiarietà sono divenute parole-chiave nel nuovo asset di competenze riscritto dalla riforma del Titolo V della Costituzione della Repubblica.
Il presente documento riporta i risultati degli incontri del Gruppo di lavoro istituito da Sviluppo Lazio con lo scopo di analizzare le prospettive di sviluppo futuro dei Poli formativi della regione Lazio.
L’analisi – che ha preso in considerazione tutte le possibili configurazioni giuridiche dei diversi organismi di gestione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (Poli formativi, Its, Poli Tecnico professionali, ecc) con la logica di individuare le criticità, ma anche la potenzialità insite nell’attuale processo di trasformazione - è stata realizzata attraverso il metodo della progettazione partecipata, che costituisce il principale approccio strutturato esistente oggi in tema di gestione di programmi e di progetti. Il Project Cycle Management (PCM), il cui utilizzo è stato già sperimentato nel contesto delle azioni integrate per lo sviluppo locale realizzate nell’ambito di azioni di sistema nazionali ed europee, si è venuto strutturando in seno a quelle organizzazioni internazionali che si occupano di sviluppo per interventi di tipo integrato, spesso multisettoriale. Si è ritenuto utile adottare il PCM in questa Linea di azione per la ricchezza dei contributi che possono derivare dalla conoscenza diretta dei problemi da parte dei responsabili dei Poli. La conoscenza dei problemi da parte dei diretti interessati rappresenta infatti un elemento di garanzia rispetto alla adeguatezza delle soluzioni individuate.
Obiettivo non secondario degli incontri è stato quello di formulare in modo condiviso proposte operative, da trasmettere alla Regione Lazio, per affrontare i problemi che si prospettano in vista delle opportunità di trasformazione/evoluzione dei Poli.
A tal fine sono stati costituiti due specifici gruppi di lavoro, i cui incontri sono stati realizzati in parallelo:
Gruppo 1: le problematiche poste dal processo di trasformazione dei Poli formativi in Poli tecnico-professionali;
Gruppo 2: le problematiche dello start-up degli Istituti tecnico superiori.
Per ciascun Gruppo sono stati realizzati due incontri, il primo finalizzato alla condivisione degli obiettivi specifici e delle azioni mirate che andranno a costruire una proposta operativa, il secondo di restituzione dei risultati del primo incontro e di approvazione del documento.
Nel corso degli incontri i partecipanti sono stati chiamati a rispondere ad una domanda-chiave (per il primo gruppo: Quale ostacolo vedete come principale per la trasformazione del vostro Polo in PTP? - per il secondo gruppo: Qual è il principale problema che vi trovate ad affrontare in fase di start-up dell’ITS?) attraverso la scrittura su cartoncini colorati di un massimo di tre problemi. A partire dalla lettura condivisa di tutte le criticità emerse, sono stati identificati gli obiettivi/azioni la cui aggregazione per similitudine o affinità ha condotto alla definizione di aree di intervento (cluster). Per ciascuna area sono state identificate possibili soluzioni già adottate dai Poli formativi regionali o in altri contesti (esempi concreti di buone prassi relative, ad es., ai modelli organizzativi, ai sistemi di governance: alle modalità di relazione tra i diversi soggetti della rete; al rapporto con le imprese e al rapporto tra sistemi produttivi e tra sistema della formazione e sistema dell’istruzione).
I due documenti predisposti dai Gruppi sono stati analizzati, discussi e portati a sintesi nel corso di un incontro congiunto tra i rappresentanti di tutti i Poli.
1. GLI ISTITUTI TECNICI SUPERIORI (ITS)
I tre step incrementali di mutamento del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, individuati dal MIUR, fino al 2006, ai prodromi del varo dello strumento ITS, possono essere così sintetizzati:
- 1999-2001 – avvio sperimentale dell’IFTS e adozione del regolamento di attuazione della legge istitutiva;
- 2002-2003 – definizione, a livello nazionale, della sua struttura e del suo impianto metodologico, delle figure professionali di riferimento e dei relativi standard delle competenze culturali comuni a tutti i percorsi e di quelle tecnico professionali, delle modalità di valutazione e di certificazione dei risultati di apprendimento, dei criteri per il riconoscimento dei crediti, del monitoraggio di sistema anche riferito agli esiti occupazionali;
- 2004-2006 – inizio della sua messa a regime attraverso la programmazione pluriennale dei piani regionali, la costituzione dei Poli formativi di settore presso istituti secondari superiori e strutture formative accreditate dalle Regioni, integrazione con le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, rafforzamento del partenariato pubblico-privato e delle misure di sostegno allo sviluppo locale e di collegamento con i distretti industriali, promozione della collaborazione multiregionale riferita alle filiere produttive, a partire dai settori calzaturiero, tessile e dell’economia del mare, avvio di piani di intervento nel Mezzogiorno per promuovere comunità di innovazione finalizzate alla diffusione della cultura scientifica e tecnologica nelle scuole superiori e nelle strutture formative, con una mobilitazione organica del sistema universitario e della ricerca[2].
Un ulteriore sviluppo al sistema dell’IFTS, secondo una ratio di rafforzamento della filiera tecnico scientifica e dell’alta formazione professionale connesse alle misure di sostegno allo sviluppo economico, è impresso dalle disposizioni della legge finanziaria 2007 e della Legge n. 40/07.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 25/01/2008) vengono adottate le Linee guida che disciplinano la riorganizzazione del sistema dell’IFTS: l'obiettivo principale espresso nel DPCM 25/01/2008 è quello di “contribuire alla diffusione della cultura tecnica e scientifica e sostenere, in modo sistematico, le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano in linea con i parametri europei”.
In particolare siffatta riorganizzazione del sistema IFTS è finalizzata a:
· rendere più stabile e articolata l’offerta dei percorsi di specializzazione tecnica superiore a giovani e adulti;
· rafforzare l’istruzione tecnica e professionale nell’ambito della filiera tecnica e scientifica attraverso la costituzione degli istituti tecnici superiori;
· rafforzare la collaborazione con il territorio, il mondo del lavoro, le sedi della ricerca scientifica e tecnologica, il sistema della formazione professionale nell’ambito dei poli tecnico-professionali (Legge n. 40/07, art. 13, comma 2);
· promuovere l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
· sostenere l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
· sostenere le politiche attive del lavoro, soprattutto in relazione alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e promuovere organici raccordi con la formazione continua dei lavoratori nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.
La denominazione di “Istituto Tecnico Superiore”, con l’indicazione del settore di riferimento, è attribuita esclusivamente alle strutture rispondenti alle linee guida contenute nell’allegato a) del DPCM 25/01/2008.
Gli Istituti di istruzione tecnica superiore (ITS) nascono dall'esigenza di realizzare dei percorsi finalizzati al conseguimento del Diploma di Tecnico Superiore, al fine di rispondere a fabbisogni formativi diffusi sul territorio nazionale, con riferimento ad ampie aree tecnologiche indicate dalla legge finanziaria 2007 e dai documenti di programmazione economica, nonché dai programmi di attività relativi ai predetti obiettivi. Questi percorsi sono progettati e gestiti dai soggetti associati di cui all’articolo 69, legge n. 144/99, per rispondere a fabbisogni formativi più strettamente collegati alle esigenze locali.
Gli ITS sono pensati per realizzare percorsi rivolti a giovani e adulti, finalizzati al conseguimento di un diploma di specializzazione tecnica superiore nelle aree tecnologiche considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell’Unione Europea:
· Efficienza energetica
· Mobilità sostenibile
· Nuove tecnologie della vita
· Nuove tecnologie per il Made in Italy
· Tecnologie innovative per i Beni e le Attività Culturali
· Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
In termini più generali di obiettivo, l'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ex Indire) evidenzia come i percorsi realizzati dagli ITS, similmente a quelli programmati nell’ambito dell’IFTS, mirino a:
- assicurare un’offerta rispondente a fabbisogni formativi differenziati secondo criteri di flessibilità e modularità;
- consentire percorsi formativi personalizzati per giovani ed adulti in età lavorativa, con il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti;
- favorire la partecipazione anche degli adulti occupati.
Inoltre sono finalizzati al raggiungimento di omogenei livelli qualitativi e di spendibilità delle competenze acquisite in esito al percorso formativo. Nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita, la certificazione dei percorsi realizzati dagli ITS e di quelli programmati nell’ambito dell’IFTS è determinata sulla base di criteri di trasparenza che favoriscono l’integrazione dei sistemi di istruzione e formazione a livello post-secondario e facilitano il riconoscimento e l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli.
L’articolazione dei percorsi realizzati dagli ITS risponde a standard minimi riferiti ai seguenti criteri:
1. ciascun semestre comprende ore di attività teorica, pratica e di laboratorio. Gli stage aziendali e i tirocini formativi, obbligatori almeno per il 30% della durata del monte ore complessivo, possono essere svolti anche all’estero;
2. i percorsi possono non coincidere con le scansioni temporali dell'anno scolastico. Per i lavoratori occupati, il monte ore complessivo può essere congruamente distribuito in modo da tenere conto dei loro impegni di lavoro nell'articolazione dei tempi e nelle modalità di svolgimento;
3. i curricula dei percorsi fanno riferimento a competenze comuni, linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali, di differente livello, nonché a competenze tecnico-professionali riguardanti la specifica figura di tecnico superiore, declinati in relazione agli indicatori dell’Unione europea relativi ai titoli e alle qualifiche;
4. i percorsi sono strutturati in moduli e unità capitalizzabili intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo;
5. i docenti provengono per non meno del 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore per almeno cinque anni;
6. i percorsi sono accompagnati da misure a supporto della frequenza e del conseguimento dei crediti formativi riconoscibili, delle certificazioni intermedie e finali e di inserimento professionale;
7. la conduzione scientifica di ciascun percorso è affidata ad un comitato di progetto, composto dai rappresentanti dei soggetti formativi che partecipano alla costituzione degli Istituti tecnici superiori e alla progettazione e gestione dei percorsi IFTS;
8. contengono i riferimenti alla classificazione delle professioni relative ai tecnici intermedi adottata dall’ISTAT e agli indicatori di livello previsti dall’Unione europea per favorire la circolazione dei titoli e delle qualifiche in ambito comunitario. Allo stato attuale si fa riferimento al quarto livello della classificazione comunitaria delle certificazioni adottata con decisione del Consiglio 85/368/CEE[3].
Nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di programmazione dell’offerta formativa, gli ITS possono essere costituiti se previsti dai Piani Territoriali. Le Regioni, nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa che è di loro esclusiva competenza, adottano i Piani Territoriali per ogni triennio, facendo riferimento agli indirizzi della programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività in linea con i parametri europei. Anche sulla base delle proposte formulate dalle Province con riferimento ai loro piani di programmazione, i piani sono oggetto di concertazione istituzionale e di confronto con le parti sociali, anche attraverso la valorizzazione del ruolo dei comitati regionali per l’IFTS.
I Piani Territoriali sono sostenuti dall'insieme delle risorse nazionali e regionali, anche messe a disposizione da altri soggetti pubblici e privati e dall’Unione Europea[4].
Gli ITS sono configurati secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione con riferimento al Titolo II, Capo I, articoli 11 e seguenti, del Codice Civile e sulla base dello schema di Statuto contenuto nell’allegato b) del DPCM 25/01/2008, e vi partecipano come enti fondatori necessari:
1. un istituto di istruzione secondaria superiore, che in relazione all’articolo 13 della legge n. 40/2007 appartenga all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione;
2. un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana);
3. una struttura formativa accreditata per l’alta formazione, ubicata nella provincia sede della Fondazione;
4. un’impresa del settore produttivo cui si riferisce l’istituto tecnico superiore;
5. un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica.
La ragione di questa scelta è ben descritta dal MIUR laddove sottolinea che gli Istituti tecnici superiori, per nascere e svilupparsi, hanno bisogno del coinvolgimento delle istituzioni competenti (Stato ed Enti territoriali), delle comunità locali, delle scuole, delle strutture formative, delle università, delle imprese, delle parti sociali, delle sedi della ricerca scientifica e tecnologica nella realizzazione di programmi pluriennali misurati sulle esigenze di valorizzazione e di sviluppo del territorio. Gli ITS necessitano di un tessuto sociale, produttivo ed economico di riferimento, della disponibilità di risorse logistiche, strumentali, professionali e finanziarie dedicate; devono essere dotati di organi di governo ben identificati, che possano operare con continuità di azione ed abbiano ruoli e responsabilità chiari e codificati. Per questi motivi, gli Istituti tecnici superiori devono avere una personalità giuridica che sia espressione di una solida collaborazione tra pubblico e privato[5].
La Fondazione di partecipazione è un istituto giuridico che costituisce il modello italiano di gestione pubblico-privata di iniziative no-profit che ha recentemente avuto maggiore diffusione. Si presenta come uno strumento flessibile e articolato, già utilizzato in altri ambiti di interesse generale e di utilità sociale per iniziative senza fini di lucro (sanità, beni culturali, ambiente, ricerca scientifica, ecc.), che coniuga l’elemento patrimoniale della Fondazione con l’elemento personale dell’associazione, agevola l’integrazione delle risorse garantendo il riconoscimento del valore delle diverse identità e dell’autonomia dei soggetti che vi partecipano.
Secondo parte della dottrina, la Fondazione di partecipazione ha “la caratteristica di far coesistere in un unico soggetto operativo imprese, associazioni culturali, ministeri, enti locali, ciascuno con la possibilità di mantenere intatte le proprie peculiarità, entrando a pieno titolo nella creatività del progetto, mantenendo al contempo la sicurezza della trasparenza dell’operare. La Fondazione di partecipazione infatti prevede sia il Consiglio generale, composto dai soli fondatori, sia il Consiglio d’amministrazione, espressione di tutte le categorie dei partecipanti alla Fondazione stessa”[6].
Questa fattispecie accoglie e razionalizza l’evoluzione de facto che l’istituto della Fondazione ha subito nel corso degli anni. Il Codice Civile disciplina la Fondazione quale patrimonio messo a disposizione per uno scopo, prevalendo dunque l’elemento patrimoniale. D'altro canto l’associazione è disciplinata invece come una aggregazione di persone per raggiungere uno scopo. In mancanza di una specifica previsione legislativa, la Fondazione di partecipazione è il frutto dell’interpretazione giuridica tesa ad innestare l’impianto della Fondazione nella dinamicità associativa. La Fondazione di partecipazione si configura dunque come un'altra istituzione di diritto privato, sintesi delle due predette figure tipiche, unione di patrimonio e persone.
Anche le Fondazioni di partecipazioni acquistano la personalità giuridica con il riconoscimento accordato mediante decreto. Sino a quando la Fondazione non è stata riconosciuta, essa opera come ente di fatto e non potrà essere destinataria di donazioni, lasciti, eredità per le quali è necessario il riconoscimento.
Mentre le Fondazioni tradizionali sono costituite da un solo fondatore che ha donato in una volta sola l’intero patrimonio della Fondazione, la Fondazione di partecipazione è caratterizzata da una pluralità di fondatori che partecipano all’atto di fondazione con modalità di intervento stabilite dall’atto costitutivo. Le eventuali adesioni non sono però contestuali ma differite nel tempo, perché la Fondazione di partecipazione non ha natura associativa e la possibilità che ai soggetti originari possano aggiungersene altri non attiene al momento genetico dell’ente ma ad una strutturazione che, quando anche formalmente contestuale, è giuridicamente successiva.
La Fondazione di partecipazione si caratterizza per essere un patrimonio di destinazione a struttura aperta, al quale ci si può iscrivere senza alcuna formalità se non quelle previste nello Statuto e che consistono il più delle volte nella adesione ai principi ed agli scopi dell’ente. Naturalmente lo scopo rimane la causa giustificativa per cui la Fondazione viene costituita, deve essere uno scopo di pubblica utilità e viene esplicitato nello Statuto. I soggetti che aderiscono alla Fondazione devono apportare denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi.
Ciò è chiaramente un’opportunità per valorizzare il ruolo e il patrimonio degli istituti tecnici e professionali e degli enti locali, nonché per integrare stabilmente le risorse messe a disposizione dal mondo del lavoro e da altri soggetti pubblici e privati. Inoltre, per incrementare progressivamente il suo patrimonio e svilupparsi, la Fondazione ha bisogno di attrarre, nel tempo, altri partecipanti, istituzionali e non, che divengano componenti dei suoi organi collegiali.
In estrema sintesi, dunque, i suoi elementi distintivi sono:
1. possibile presenza di enti pubblici sia in veste di fondatori sia mediante propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione;
2. presenza di fondatori costituiti da privati, aziende od enti finanziatori;
3. presenza di aderenti e sostenitori i quali, mediante versamento di somme di denaro una tantum o periodiche ovvero attraverso la prestazione di lavoro volontario od ancora mediante donazione di beni materiali od immateriali, contribuiscono in modo determinante alla sopravvivenza dell’Ente ed al perseguimento delle sue finalità.
La costituzione della Fondazione di partecipazione, al pari di tutte le altre Fondazioni, richiede l’atto pubblico di cui lo Statuto verrà a costituire parte integrante. Le Fondazioni acquistano personalità giuridica con il riconoscimento accordato mediante decreto e iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, articolo 1.
Tutte le competenze relative al riconoscimento ed al controllo delle Fondazioni sono dunque trasferite al Prefetto nella cui provincia è stabilita la sede dell’ente. Entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento, il Prefetto provvederà all’iscrizione della Fondazione nel Registro delle persone giuridiche, salvo la necessità di integrazioni alla documentazione.
Per le Fondazioni di partecipazione è previsto uno specifico assetto patrimoniale, determinato in un patrimonio in senso generale e in un Fondo di gestione. Il patrimonio della fondazione è costituito:
· dal Fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
· dai beni mobili ed immobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli acquistati;
· da contributi dello Stato o da Enti territoriali, dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del Patrimonio;
· dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio possono essere destinate ad incrementare il Patrimonio.
Il Fondo di gestione è costituito:
· dalle rendite e dai proventi derivanti dal Patrimonio;
· dalle donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;
· dai contributi volontari dei Fondatori, Partecipanti e Sostenitori;
· dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse (fra le attività strumentali, accessorie e connesse per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può opportunamente inserire nello Statuto la amministrazione e gestione dei beni posseduti, la partecipazione, sempre in via accessoria e strumentale a società di persone e/o di capitali, ecc.).
La Fondazione di partecipazione, al pari di altre soggettività simili, deve necessariamente configurarsi con un assetto organizzativo che preveda:
1. Consiglio di amministrazione, composto da rappresentanti eletti dai fondatori, dagli aderenti e sostenitori, cui è affidato il compito di deliberare sugli atti essenziali della vita dell’Ente;
2. Collegio dei revisori;
3. Assemblea di partecipazione, composta dagli aderenti e sostenitori, cui è affidato il compito di fornisce parere consultivo sui bilanci e di formulare proposte per la programmazione dell’attività dell’ente. L’Assemblea può eleggere propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione.
Per quanto invece attiene specificamente il governo dell’ITS, esso è affidato al Consiglio di indirizzo costituito in modo tale che tutti i soggetti fondatori siano rappresentati. I programmi, le attività e gli aspetti tecnici e scientifici sono di competenza del Comitato tecnico–scientifico, costituito da persone particolarmente qualificate nel settore d’interesse dell’ITS nominate dal Consiglio di indirizzo.
1.2 Le linee-guida della Regione Lazio
La Giunta regionale del Lazio con la DGR n. 119 del 06/03/2009 ha approvato il Piano territoriale triennale per l'istruzione e le formazione tecnica superiore avviando così sul proprio territorio la sperimentazione degli Istituti di istruzione tecnica superiore.
A tale atto normativo, ne ha fatto seguito un altro, la DGR n. 902 del 27/11/2009, che ha normato lo schema dell’Accordo di Programma tra la Regione Lazio e le Province di Roma, Frosinone, Latina, Viterbo e Rieti, finalizzato all’individuazione di enti pubblici, università ed imprese per la costituzione degli Istituti tecnici superiori, configurati secondo lo standard organizzativo della Fondazione di partecipazione. Significativo il portato dell'allegato 1 alla DGR 902/2009, che determina le “Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori”.
Similmente alla Regione Lazio, anche altre Amministrazioni regionali hanno legiferato in materia: vale la pena richiamare a titolo esemplificativo la DGR della Lombardia n. 239 del 14/07/2010 e la DGR della Toscana n. 980 del 24/11/2008.
Le Linee guida della Regione Lazio, in conformità con le disposizioni nazionali in ambito di IFTS e Fondazioni già richiamate in precedenza, fissano i riferimenti per la composizione e l'attività degli ITS da sottoporre ad approvazione, che è qui opportuno riportare schematicamente:
Gli istituti tecnici e gli istituti professionali del Lazio, statali o paritari, sono invitati a presentare le proprie candidature quali istituzioni di riferimento per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, secondo il modello organizzativo della Fondazione di partecipazione prendendo a riferimento lo schema di statuto di cui all’allegato b) del DPCM 25 gennaio 2008, in partenariato con enti di formazione professionale, accreditati dalla Regione per l’ambito della formazione superiore, imprese dell’ambito settoriale cui intende riferirsi l’Istituto Tecnico Superiore, dipartimenti universitari o altri organismi appartenenti al sistema della ricerca scientifica e tecnologica, enti locali. I soggetti, componenti il partenariato che può candidarsi per la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori, secondo lo standard organizzativo minimo, sono:
· un istituto di istruzione secondaria superiore, statale o paritario, appartenente all’ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della Fondazione, che abbia nel proprio Piano dell’offerta formativa un indirizzo di studio riferibile all’ambito settoriale per cui si candida;
· un ente di formazione professionale, accreditato dalla Regione per l’ambito della formazione superiore, ubicato nella provincia sede della Fondazione;
· una impresa del settore produttivo cui si riferisce l’Istituto tecnico superiore;
· un dipartimento universitario o altro organismo appartenente al sistema della ricerca scientifica e tecnologica;
· un ente locale (comune, provincia, città metropolitana, comunità montana).
Fatto salvo il rispetto dello standard minimo, saranno accolte anche candidature che presentino un partenariato più ampio, sia in termini quantitativi (ad es. molteplici istituzioni scolastiche, enti di formazione, imprese, ecc.), sia per quanto attiene alla partecipazione di soggetti diversi da quelli indicati nello standard minimo. Si ritiene infatti che, attraverso l’ampliamento dei soggetti coinvolti, possa risultare potenziata la qualità delle attività e dei servizi offerti dalla Fondazione ITS.
Allo stesso fine, l’istituto tecnico o professionale, che promuove la costituzione della Fondazione di partecipazione in qualità di fondatore e ne costituisce l’ente di riferimento (ferma restando la distinta ed autonoma sua soggettività giuridica rispetto all’ITS), potrà inoltre documentare l’esistenza di reti costituite con altri soggetti formativi interessati a mettersi in relazione con la Fondazione; i soggetti componenti di tali reti devono in ogni caso fare riferimento alla stessa area tecnologica nazionale e allo stesso ambito settoriale, nonché alle figure che saranno successivamente determinate a livello nazionale.
Per quanto riguarda l’adesione delle imprese al partenariato che si candida, , in considerazione degli obiettivi del Piano triennale regionale, con riferimento alla realizzazione di un’offerta specificamente finalizzata a corrispondere alla richiesta di tecnici superiori proveniente dal mondo del lavoro, in particolare dalle piccole e medie imprese, ed ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati, i soggetti proponenti sono invitati a presentarsi con un numero di imprese, del settore produttivo cui si riferisce l’ITS, superiore allo standard minimo.
Per quanto riguarda invece i soggetti del partenariato dell’ambito formativo (istituzioni scolastiche, enti di formazione professionale, dipartimenti universitari o altri organismi appartenenti al sistema della ricerca scientifica e tecnologica), gli stessi devono dichiarare di essere in possesso di pregressa esperienza nella realizzazione di percorsi IFTS.
I soggetti proponenti dovranno inoltre indicare la sede individuata per la Fondazione ITS e la/le sedi per le attività formative, qualora non coincidenti, nonché le caratteristiche delle varie sedi, nel caso in cui queste siano plurime, in termini di funzionalità allo svolgimento delle diverse attività.
Le candidature devono essere corredate da un piano triennale di attività, predisposto secondo le indicazioni della programmazione regionale ed in relazione alle seguenti tipologie di intervento:
- ricognizione dei fabbisogni formativi per lo sviluppo, a partire dalle esigenze di innovazione scientifica, tecnologica ed organizzativa (fabbisogni di innovazione) delle imprese attive sul territorio, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese ed alle sedi della ricerca;
- progettazione e realizzazione dell’offerta di formazione alta e specialistica, secondo le opzioni di filiera e le rispettive specifiche previste dal Piano triennale regionale, relativamente alle figure di tecnico superiore di riferimento a livello nazionale;
- accompagnamento al lavoro dei giovani specializzati a conclusione dei percorsi;
- realizzazione di attività di aggiornamento destinate al personale docente di discipline scientifiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale, oltre a quelle relative alla formazione dei formatori impegnati nella realizzazione dei percorsi;
- orientamento dei giovani verso le professioni tecniche, anche con il coinvolgimento delle loro famiglie;
- ogni altra attività che risponda alla programmazione regionale riferita all’offerta di formazione alta, specialistica e superiore.
Il piano deve specificare le tipologie di intervento che si intendono realizzare in ogni annualità, nonché evidenziare il piano finanziario del triennio, impostato per singole annualità. A seguito del decreto che dovrà determinare i diplomi di tecnico superiore e i certificati di specializzazione tecnica superiore, con l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento a livello nazionale dell’offerta ITS, ivi compresi i relativi standard delle competenze, ad oggi non ancora emanato dal Governo, la Regione provvederà ad attribuire ad ogni ITS le figure nazionali di relativa competenza.
Il più recente atto dispositivo della Regione Lazio in materia è costituito dalla determina dirigenziale della Direzione regionale Istruzione, programmazione dell’offerta scolastica e formativa, diritto allo studio e politiche giovanili, n° 4379 del 15 ottobre 2010, avente ad oggetto il cofinanziamento regionale per la costituzione di Istituti tecnici superiori ai sensi della Legge 26 febbraio 2010 n. 25, articolo 7, comma 5 quater, che stabilisce:
- “di ritenere ammissibili, sulla base delle risorse disponibili al cofinanziamento regionale i seguenti progetti:
1. Progetto per l’attuazione dell’ITS con istituto di riferimento I.P.S.I.A. di Pomezia – Polo formativo Chimico farmaceutico – Area Tecnologica di riferimento Nuove tecnologie per la vita;
2. Progetto per l’attuazione dell’ITS con istituto di riferimento I.T.I.S. M.O.V.M. “Don G. Morosini” di Frosinone – Polo Aerospaziale e settori innovativi dell’ingegneria- Area Tecnologica di riferimento Mobilità sostenibile;
3. Progetto per l’attuazione dell’ITS con istituto di riferimento I.P.S.A.A. “San Benedetto” di Latina – Polo Agroindustria e agroalimentare – Area Tecnologica di riferimento Nuove tecnologie per il Made in Italy/Agroalimentare;
4. Progetto per l’attuazione dell’ITS con istituto di riferimento Istituto SOGEIS SrL “J.J.Rousseau” di Viterbo – Polo formativo per la produzione, manutenzione – Area Tecnologica di riferimento Nuove tecnologie per il Made in Italy/Sistema casa;
nonché,
- di poter trasmettere al MIUR gli atti costitutivi pervenuti dai sotto elencati Istituti, al fine della conclusione dell’iter amministrativo a carico della Regione Lazio:
· I.P.S.I.A. di Pomezia – Polo formativo Chimico farmaceutico – Area Tecnologica di riferimento Nuove tecnologie per la vita;
· Istituto SOGEIS SrL “J.J.Rousseau” di Viterbo – Polo formativo per la produzione, manutenzione – Area Tecnologica di riferimento Nuove tecnologie per il Made in Italy/Sistema casa;
· I.P.S.A.A. “San Benedetto” di Latina – Polo Agroindustria e agroalimentare – Area Tecnologica di riferimento Nuove tecnologie per il Made in Italy/Agroalimentare”.
In data 10/11/2010, il MIUR ha pubblicato un documento relativo agli Istituti tecnici superiori costituiti in Italia, attualmente in numero di 50, di cui i seguenti 7 in Regione Lazio (vedi Allegato 1 al presente documento):
· Tecnologie dell'informazione e della comunicazione, Istituto Professionale “R. Rossellini”, Roma;
· Mobilità sostenibile, Mobilità delle persone e delle merci, IIS “Caboto”, Gaeta (LT);
· Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali/turismo, IIS “Domizia Lucilla”, Roma;
· Nuove tecnologie per il made in Italy, Sistema alimentare, ITIS “Pietro Canonica”, Vetralla (VT);
· Nuove tecnologie della vita, IPSIA “Cavazza”, Pomezia (RM);
· Nuove tecnologie per il made in Italy, Sistema agroalimentare, IPSSA “San Benedetto”, Borgo Piave (LT);
· Nuove tecnologie per il made in Italy, Servizi alle imprese, Istituto paritario “SO.GE.IS”, ITAS paritario “Russeau”, Viterbo.
Con tali provvedimenti, per utilizzare le parole del prof. Claudio Demartini[7], “l’istruzione tecnica superiore si inserisce nello scenario culturale fondato sull’integrazione della scienza, della tecnica e della tecnologia. Mentre la scienza rappresenta la conoscenza elaborata attraverso l’osservazione della natura, il termine infatti ha origine dal latino scientia, che esprime proprio la conoscenza, il termine tecnologia deriva dal greco τεχνολογία, e rappresenta letteralmente il discorso sull'arte, essendo arte il saper fare.
In questo quadro l’istruzione tecnica superiore è chiamata a svilupparsi attraverso la costruzione di una relazione sistemica anche con l’università, per esprimere un’alternativa ai percorsi accademici, mettendo dunque in pratica i suggerimenti che l’OCSE esprimeva sin dal 1998 rispetto all’anomalia tutta italiana dell’assenza di un percorso non accademico nell’alta formazione (Higher Education). La missione dell’Istruzione Tecnica Superiore è dunque quella di promuovere una risposta adeguata alle esigenze di innovazione delle imprese, coniugando gli aspetti strettamente tecnologici con le componenti economiche, ambientali e sociali, rispettando i paradigmi dell’etica e della sostenibilità delle azioni produttive e commerciali”.
L'idea alla base di questa fase del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore ruota intorno ad un soggetto ITS capace di concorrere alla diffusione della cultura tecnica e scientifica ed al raggiungimento degli obiettivi della futura riorganizzazione del sistema stesso. In relazione alla diffusione della cultura tecnica e scientifica, gli ITS dovranno contribuire, in modo sistematico, a sostenere le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo italiano attraverso:
· un’offerta più stabile e articolata di percorsi di specializzazione tecnica superiore per corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici di diverso livello;
· il rafforzamento del ruolo degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell’ambito della filiera tecnico-scientifica;
· una maggiore collaborazione tra le realtà del territorio nell’ambito dei poli tecnico-professionali di cui all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/07;
· l’orientamento permanente dei giovani verso le professioni tecniche e le iniziative di informazione delle loro famiglie;
· l’aggiornamento e la formazione in servizio dei docenti di discipline scientifiche, tecnologiche e tecnico-professionali della scuola e della formazione professionale;
· il sostegno delle politiche attive del lavoro in raccordo con la formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell’apprendimento permanente per tutto il corso della vita.
Il progetto di riforma del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore, nella previsione del MIUR, vede gli istituti tecnici superiori come parte integrante dei Poli tecnico-professionali previsti dall’articolo 13 della Legge n. 40/07: a tal fine, il MIUR prevede la possibilità di costituire consorzi tra istituti tecnici superiori, istituti tecnici e professionali e strutture formative accreditate dalle Regioni, con gli strumenti dell’autonomia scolastica e nell’ambito delle scelte di programmazione dell’offerta formativa di competenza regionale[8].
Il processo di revisione e rilancio dell’istruzione tecnica e professionale, pertanto, vede nella riorganizzazione della specializzazione tecnica superiore e nella costituzione degli Istituti Tecnici Superiori non tanto un approdo, quanto una significativa tappa. Senza dubbio il valore aggiunto di questo step è la configurazione di un soggetto che è motore di una rete e centro di governance delle politiche del settore.
Con la costituzione degli ITS, si assiste infatti alla nascita e alla presenza sul territorio di un soggetto nuovo, che può giocare un ruolo importante nelle politiche attive del lavoro, con particolare riferimento alla transizione dei giovani nel mondo del lavoro e alla formazione permanente dei lavoratori[9] in quanto attraverso di esso si rafforzano la concertazione istituzionale e il confronto con le parti sociali a livello di territorio, si valorizza il ruolo degli enti locali e del mondo del lavoro, si favorisce l’integrazione tra i sistemi formativi e le sedi della cultura scientifica e tecnologica.
Un soggetto che diventa appunto un network, uno snodo di approcci e interventi integrati, una visione unitaria e pluralista di dinamiche complesse che si deve tentare di ridurre a sistema.
Anche in ambito di ITS restano sul tavolo alcune questioni critiche, già sperimentate in altri contesti organizzativi: su tutte, il rapporto con le imprese e con le università.
Rispetto alla partecipazione delle imprese, essa resta determinante per cogliere i bisogni del mercato e disegnare i profili professionali, fino al dettaglio del set di competenze ad essi collegato. Spesso, in passato, il contributo delle imprese non ha avuto il peso specifico atteso soprattutto nella fase di programmazione e gestione dell’attività di formazione, rimasta appannaggio del mondo dell'istruzione o delle agenzie di formazione.
Per quanto riguarda invece l'università appare necessario scavalcare relazioni meramente formali di adesioni agli organismi che compongono l'ITS, o altri soggetti simili in passato e nel presente, o di riconoscimenti di crediti che risultano essere di minimo rilievo per un'eventuale carriera universitaria, e creare invece un ambiente di approcci e finalità condivise.
Inoltre, considerata la strategicità che viene attribuita in questa fase agli ITS come necessaria sede di integrazione tra università, istituzioni scolastiche, enti di formazione e imprese, appare necessario stimolare un'attenta riflessione rispetto alle opportunità/possibilità di collegamento tra formazione continua, ITS e fondi interprofessionali (anche secondo quanto previsto nelle“linee guida per la costituzione degli istituti tecnici superiori” ove tra gli obiettivi si scrive “stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori, nel rispetto delle competenze delle parti sociali in materia”). Questo tema sollecita un confronto con gli attori istituzionali e le parti sociali in considerazione del rispetto dell’autonomia dei fondi interprofessionali, che hanno oggettive difficoltà di intervento diretto nelle Fondazioni ITS la cui offerta è rivota prevalentemente a persone non occupate.
Si richiamano di seguito i punti attorno a cui si è particolarmente concentrata l’analisi sviluppata nell’ambito del Gruppo di lavoro Sviluppo Lazio – Poli Formativi.
Ruolo del MIUR nella governance del sistema
Il MIUR ha coinvolto le associazioni, in particolare quelle di categoria, ad es. per la definizione degli standard formativi nel settore ICT. A tal proposito Confindustria ha chiesto di utilizzare le declaratorie comuni già utilizzate a livello comunitario.
I tavoli di lavoro del MIUR coinvolgono anche le Regioni: sono infatti composti da esperti nominati dallo stesso Ministero o su indicazione della Conferenza Stato-Regioni, tra cui rappresentanti regionali, e dai referenti delle Fondazioni ITS.
Qual è il ruolo del MIUR? Il DPCM 25/01/2008 è una regola generale di start-up o di standard o altro?
Ad oggi, la mancata definizione delle figure professionali rappresenta un impedimento all’avvio del sistema e si prevede che l'iter di approvazione di tali profili in Conferenza Stato-Regioni sarà travagliato, perchè nelle Regioni c'è un forte senso di autonomia:.
Rispetto ai finanziamenti, il MIUR ha liberato 10 milioni di euro, in accordo con la Conferenza Stato-Regioni, per le Fondazioni costituite al 15 ottobre 2010: un finanziamento per la fase di start-up. Il problema ora è capire quali fondi saranno disponibili per il futuro, ma non legati a bandi, ovvero a singoli progetti, quanto piuttosto finanziamenti per un'attività che deve essere ricorrente. Il problema dei finanziamenti riguarda già la definizione del budget per la seconda annualità, che resta tutta da programmare. E’ necessario sapere quali servizi si possono garantire e non tanto se sopravvive la Fondazione.
Rispetto alla tempistica, il MIUR ha posto settembre come deadline, ma al momento non si è capito se a tale data si avvierà l’attività di comunicazione/promozione o invece le attività di formazione.
Resta il problema dell’impiego del personale scuola/università.
Coinvolgimento attivo delle imprese
C’è un forte interesse delle associazioni degli industriali rispetto agli ITS; le Camere di Commercio sono infatti entrate nelle Fondazioni di vari ITS.
Infatti, gli ITS nascono perché ci si è resi conto che dell’istruzione tecnica non si può fare a meno né a livello pedagogico né a livello produttivo. Pertanto, almeno a livello teorico, si è deciso di dare ascolto in maniera seria alle esigenze produttive delle imprese, che dichiarano di avere necessità di alcune figure professionali che il sistema dell’istruzione e della formazione non riesce a garantire.
Purtroppo, però, le imprese non si fidano dei soggetti che in questo momento hanno la delega a formare determinate qualifiche e soprattutto non si fidano degli attori decisionali del sistema (Ministero e Regione).
Percezione da parte della Regione
Gli ITS rappresentano uno strumento che opera come alternativa strutturale ad un’altra tipologia di percorso formativo superiore e, in questa veste, richiedono un’assunzione di responsabilità da parte della Regione al fine di non considerare l’attività da essi svolta alla stregua delle attività a bando.
Definizione condivisa della soggettività giuridica dell’ITS
Esistono al momento difficoltà normative che impediscono l’effettiva operatività dell’ITS e della Fondazione di partecipazione. Permangono infatti differenze di interpretazione e di approccio tra i soggetti che la legge individua come rilevanti in un sistema che in parte è soggetto a finanziamenti regionali o nazionali e in parte è disciplinato dalla normativa nazionale della Fondazione di partecipazione.
Il riconoscimento da parte delle prefetture anziché da parte delle regioni, sembra rispondere all’esigenza di dare un raggio d'azione nazionale e europeo alle Fondazioni e di garantire loro la possibilità di muoversi a livello ultra-regionale ma, al contempo, le attività che verranno sviluppate sembrano assoggettate ai vincoli della legislazione regionale.
Definizione qualifiche professionali
Le necessità delle imprese vanno nella direzione di qualifiche flessibili e integrabili/aggiornabili nel tempo.
Il MIUR, tramite l'Ansas, ha chiesto ad ogni singolo ITS una proposta sulle figure professionali di riferimento, proposte ad oggi oggetto di discussione dei singoli tavoli tecnici del Ministero sulle qualifiche.
La proposta inviata è strutturata in ambito, proposta di figura professionale e competenze di riferimento per tale figura.
Il MIUR non sta lavorando sui profili ma sulle figure, proprio per non entrare nel merito dei profili, su cui potrebbe lavorare la Regione, a partire dalle schede inviate dagli ITS all'Ansas. La Regione dovrebbe sostenere i contenuti di quelle schede.
Riguardo alla questione delle aree tecnologiche molto ampie, vi è una richiesta da parte degli ITS, ad esempio nell'area tecnologica, che le figure professionali siano molto ampie. L'indicazione che viene dai tavoli tecnici del MIUR è che le Fondazioni abbiano un ampio raggio di azione: l'ITS sarà una delle attività ma non esclusiva, ci sarà anche lifelong learning, innovazione, trasferimento tecnologico, creazione di impresa.
Comunicazione e coinvolgimento dell’utenza
Vi sono difficoltà nel coinvolgere l’utenza dell’offerta ITS, vale a dire i giovani e le loro famiglie (e questo coinvolgimento deve essere realizzato nei prossimi due-tre mesi). E’ difficile infatti trovare le motivazioni da offrire ad un giovane o ai suoi genitori perché essi scelgano l’ITS invece dell’Università o di un corso di formazione o un periodo di apprendistato per un pronto accesso al mercato del lavoro.
L’ITS, per essere appetibile, deve infatti essere innovativo e strettamente legato all’impresa. L’impresa è l’attrattore fondamentale: per coinvolgerla è necessario rispondere ai suoi bisogni, soddisfare i suoi requisiti (che sono poi le esigenze produttive) piuttosto che quelli dell’attività didattica.
Requisiti di ingresso
I requisiti d’accesso attualmente previsti sono molto difficili da soddisfare (ECDL avanzato e lingua inglese livello B2) e rappresentano un ostacolo determinante per il coinvolgimento dell’utenza. Soprattutto, però, risultano essere un filtro molto più difficile da superare rispetto a quelli previsti dall’Università, ovvero il solo possesso del titolo di diploma di maturità.
Inglese B2 è un'eccellenza dei licei linguistici. Per l’ECDL avanzato non ci sono i software all'interno degli istituti scolastici.
Pertanto è necessario mettere in condizione i possibili partecipanti ai corsi ITS di acquisire tali titoli, il che vuol dire avere capacità di spesa. Ce l'hanno le Fondazioni, ma dovrebbero aver dischiuso il trasferimento dei soldi, avere completato tutti gli iter procedurali. In 5 ITS su 7 sono a questo punto, quindi già 2 sarebbero in sofferenza. Poi bisogna attivare una procedura di gara: coi tempi si arriverebbe quindi a fine marzo, i ragazzi sarebbero già prossimi alla preparazione per la maturità (un corso per l'ECDL prevede 7 esami, almeno 10 ore a corso, un corso dalle 50 alle 70 ore a seconda delle competenze in ingresso).
Gli ITS sono gestori di risorse pubbliche, ci sono nel Lazio Fondazioni in settori quasi unici in Italia, che al Sud ad esempio non ci sono. Quindi sarebbe necessario agire in evidenza pubblica con bando di gara a livello nazionale; per fare ciò è necessario garantire almeno 20-30 giorni per rispondere/ricevere le domande. Dunque si arriva a maggio/giugno, i ragazzi sono in maturità, tutta la formazione si sposta a settembre. I migliori sono entrati all'università, chi non ci voleva andare è andato a lavoro.
Studenti fuori sede
La normativa attuale degli ITS prevede una riserva di posti (30%) a beneficio degli studenti fuori sede, ma non vi sono risorse sufficienti a garantire che questa garanzia possa essere concretamente resa disponibile. Ciò è fondamentale se si riconosce all’ITS una valenza multiregionale e nazionale. Il problema è di risorse, gli ITS non possono pensare di richiedere rette più alte delle Università: quindi non oltre i mille euro. Si possono sfruttare i buoni rapporti con le Università per usufruire delle loro strutture residenziali. Restano comunque i problemi di trasporto per le sedi. Sono un po’ tutte problematiche tecnico-politiche.
C'è bisogno di certezze: quale budget a disposizione per fare una convenzione, ad esempio, con una struttura alberghiera?
La rete regionale
Gli ITS del Lazio hanno costituito una rete, di cui fanno parte tutti i soggetti costituiti.
Si tratta di un coordinamento, che va in ogni caso rafforzato, per le azioni (perlopiù di diffusione e promozione) di sistema, ma anche per trovare delle economie e un'ottimizzazione delle azioni trasversali a tutti gli ITS.
1.4 Le proposte per fronteggiare le criticità legate alla fase di start-up degli ITS
Area NORMATIVA
· Rapporto/interazione Regione/MIUR
· La Regione deve definire le regole dell’ITS: la 1509/2002 è molto rigida, è uno strumento improprio per l’ITS. Andrebbero ridefinite le procedure di governance della rendicontazione, semplificandole. Alcune attività vanno svincolate da tali regole, anche solo per poter attrarre fondi privati.
· È necessaria una modifica della legislazione regionale, affinché sia il codice civile a regolare il sistema ITS. Visto che la soggettività giuridica che è stata imposta e che gli ITS hanno assunto è quella delle Fondazioni di partecipazione, va applicata la normativa che regola tale istituto, cioè il codice civile.
· Flessibilità/possibilità di utilizzo dei fondi interprofessionali, soprattutto nelle azioni in cui vi è un coinvolgimento delle parti sociali. Nei fondi interprofessionali, il 70% delle risorse è destinato alla singola impresa, mentre il 30% è accantonato per azioni di sistema: è questo 30% che potrebbe essere impiegato nell’ITS.
· Impiego del personale scuola/università: è necessario avere un'indicazione da scuola/università ma le selezioni andranno effettuate dalle Fondazioni su skill job necessari e non su titoli. Ci potrebbe essere un abbattimento dei costi del 50%, perchè una risorsa potrebbe lavorare fino a copertura delle ore di servizio e l'eccedenza di lavoro verrebbe retribuita con i fondi a disposizione dell’ITS. Il MIUR ha già recepito queste indicazioni, resta da verificarne la concreta attuazione.
· Il MIUR non sta lavorando sui profili ma sulle figure, proprio per non entrare nel merito dei profili, su cui potrebbe lavorare la Regione, a partire dalle schede inviate dagli ITS all'Ansas. La Regione dovrebbe sostenere i contenuti di quelle schede.
· Rispetto ai requisiti molto selettivi di accesso all’ITS, si potrebbe chiedere al MIUR di considerarli in questa fase requisiti in uscita, accertato un livello necessario in ingresso per poterli acquisire: questo sarebbe un punto forte da sostenere in Conferenza Stato-Regioni. Per il futuro, invece, tali titoli in ingresso potrebbero essere un obiettivo al quale si tende entro i prossimi due anni.
· Le Fondazioni non possono occuparsi solo degli IFTS, altrimenti lo strumento ha poco impatto.
Area ISTITUZIONALE
· La definizione della normativa di riferimento è una questione da portare in Conferenza Stato-Regioni.
· Sarebbe opportuno validare i tavoli di confronto attivati dagli ITS a livello regionale.
· Andrebbe istituito un tavolo regionale con la partecipazione delle associazioni datoriali/imprenditoriali.
· La definizione delle figure professionali non può avvenire per area tecnologica ma in base alle istanze di un singolo ITS nella considerazione delle specificità territoriali.
· Creare una Cabina di regia regionale (ma anche interregionale, settoriale e tra le Fondazioni stesse), per poter ragionare su questioni macro: ad esempio, quanti studenti possono essere accolti da fuori regione? Che esigenze di residenzialità e di trasporto ne conseguono? ma anche per valorizzare le esperienze pregresse ed avere maggiore coordinamento; per attrarre finanziamenti esteri è necessario fare sistema tra uffici dei diversi ministeri, tra le regioni, all'interno della regione (collaborazione più efficace tra servizi e produzione).
· La Regione dovrebbe svolgere un ruolo propositivo rispetto a questioni di ordine generale in Conferenza Stato-Regioni. Ad esempio: spot a livello regionale, finanziamenti comuni, partecipazione a incontri zonali trasversali e settoriali. Dovrebbe chiedere alla Conferenza Stato-Regioni di coniugare – coinvolgendo expertise locali, regionali, nazionali - l'esigenza opposta di specificità locali e di standard nazionali. Gli esiti dei tavoli di lavoro sulle figure dovrebbero essere condivisi per il tramite della Regione con tutti gli ITS.
Area TEMPISTICA/OPERATIVITA’
· La comunicazione/informazione/promozione degli ITS deve avvenire a tre livelli: Ministero, Regioni e ITS, con un messaggio coordinato e condiviso.
· È necessario valorizzare il periodo di stage/pratica, a cui si collega un’organizzazione didattica più flessibile.
· E’ fondamentale rivedere i requisiti di ingresso ai percorsi ITS, perché quelli attualmente previsti sono molto difficili da soddisfare (ECDL avanzato e Lingua inglese livello B2).
· E’ necessario prevedere delle risorse per la copertura delle spese degli studenti fuori sede, considerato che la normativa di riferimento prevede una riserva di posti (30%) a beneficio di tali soggetti.
· Certezza di risorse finanziarie (e tempi di erogazione) e programmazione (condivisione di scelte strategiche) oltre la prima annualità.
· Rivalorizzare aree dismesse, con agevolazioni fiscali (misura prevista anche nel POR FESR).
· Potenziare le attività di ricerca, per essere generatori di nuove opportunità di lavoro.
· Favorire la creazione di raccordi con sistemi finanziari, con la consapevolezza che tali sistemi sono interessati solo se a valle c'è una creazione di impresa e un ritorno dei loro investimenti, ma la produzione/l'impresa non ha i tempi burocratici della pubblica amministrazione.
· Semplificare le modalità di interazione con le aziende: poche informazioni determinanti, cosa vuoi e quanto ti costa. Bisogna sapere se quello che si propone è sostenibile.
· Individuare indicatori validi, macroeconomici, microeconomici, della legislazione del settore, delle difficoltà del settore, in un approccio per obiettivi e non solo in termini di riconoscimento/ammissibilità della spesa in base a previsioni ex-ante che non è mai possibile fare in termini esatti. E’ il caso di proporre una responsabilità sociale di impresa, settore bancario e assicurazioni, ovvero una garanzia di un fondo privato, che però interviene solo in caso di creazione di impresa a valle, di programmazione, di condivisione strategica, di creazione di nuovi prodotti finanziari. Questo approccio richiede una Cabina di regia forte ed efficiente.